Non è che si debba trovare una scusa per andare a Trieste. Merita di essere vissuta, con calma. Non da turisti, da viaggiatori. Per conoscerla, per capirla, per respirarne lo spirito. Non basta un fine settimana. Non basta andare a San Giusto, a piazza dell’Unità, al Molo Audace e al Ponte Rosso, o al Castello di Miramare. Come fai a capire se non perdi tempo, più volte, al Caffè degli Specchi? Come fai a capire se non frequenti l’Antico Caffè San Marco e non ti soffermi nella sua libreria? Se non la scopri camminando, gustando ogni angolo, ogni incrocio? Se non ti impregni della sua cultura, delle sue culture?
 Tuttavia, scopro, una scusa adesso c’è. Martedì 28 gennaio riapre, dopo un lungo restauro, la libreria antiquaria che fu di Umberto Saba. Libreria Antica e Moderna la chiamò, quando la fondò nel 1919. il «nero antro funesto», come la definì in un catalogo. Borgo Teresiano. Via San Nicolò. A due passi dal Ponte Rosso e dal Molo Audace. Ci sarò passato davanti, ma non ci sono mai entrato. O forse sì, ma non me lo ricordo. Eppure ho vissuto a Trieste e ci sono tornato, per un motivo o per l’altro, e in fondo anche per nostalgia, decine di volte. Eppure quella libreria mi manca.
Tuttavia, scopro, una scusa adesso c’è. Martedì 28 gennaio riapre, dopo un lungo restauro, la libreria antiquaria che fu di Umberto Saba. Libreria Antica e Moderna la chiamò, quando la fondò nel 1919. il «nero antro funesto», come la definì in un catalogo. Borgo Teresiano. Via San Nicolò. A due passi dal Ponte Rosso e dal Molo Audace. Ci sarò passato davanti, ma non ci sono mai entrato. O forse sì, ma non me lo ricordo. Eppure ho vissuto a Trieste e ci sono tornato, per un motivo o per l’altro, e in fondo anche per nostalgia, decine di volte. Eppure quella libreria mi manca.
Arrivai a Trieste, bambino, alla fine 1961. Tra il tram di Opcina e i bagni di Barcola, tra i perfidi scherzi ai ciabattini che lavoravano negli androni, un giro al Tergesteo, il carbone di San Nicolò e una visita scolastica al Revoltella, per non dire dei 4 novembre al sacrario di Redipuglia, io, “meridionale”, stavo per diventare triestino. Mi innamorai di tutto, dal fiammante Carso autunnale, del golfo abbagliante, del tram di Opcina (che non funziona più) e persino del santuario mariano di Monte Grisa allora in costruzione. La dovetti abbandonare. Ma decisi di tornarci, alla caserma di via Rossetti, oggi abbandonata. Forse sarà trasformata in polo scolastico.
I primi anni ero troppo piccolo per frequentare librerie. Quando tornai ero troppo indaffarato. Poi ho sempre pensato “ci vado”, ma non l’ho fatto. L’ultima volta a Trieste, non così lontana, era chiusa. Sono pentito. Devo riparare. Anche perché la libreria antiquaria di Saba l’ho incrociata lavorando alla pubblicazione del diario di un altro triestino, il giornalista e diplomatico Attilio Tamaro. Erano culturalmente diversi l’irredentista nazionalista, poi fascista, e il poeta, vociano, anche lui irredentista e collaboratore del “Popolo d’Italia”, ma solo durante la Grande Guerra. Eppure già nella sua Storia di Trieste (1924) Tamaro definì Saba «scrittore di sincera originalità e di fervida ispirazione […] giustamente molto lodato tra i giovani e migliori poeti italiani». Rimasero sempre amici. Quando Tamaro lo incontra a Roma, nel febbraio del 1945, «felice per l’imminente uscita della nuova e definitiva edizione del Canzoniere per Einaudi», lo riscopre «più ebreo che mai e comunista, ma molto caro e sempre geniale». E Tamaro non era antisemita.
 D’altra parte, sia pure lontani, il rapporto tra Tamaro e Saba non era mai cessato. Lo confermano le minute di alcune lettere degli anni Trenta. Il diplomatico è a Helsinki quando gli scrive: «Caro Saba,quando ho ricevuto, oggi, la sua lettera, ho creduto che vi avrei trovato dentro qualche rimprovero, che sapevo ben meritato. Invece non c’erano che cortesie. Da molto tempo la devo ringraziare delle tre poesie, che mi ha mandato. Non so dirle che impressione mi faccia vederla ritornare con così appassionata insistenza al tempo della sua fanciullezza: si ha talvolta la sensazione che lei soffra oggi come soffrì allora, o, meglio, che soffra per quanto non poté soffrire in quel tempo lontano. L’estrema semplicità del verso non solo riproduce con vivissimo risalto la sua visione, ma ci mette anche in contatto immediato con la sua anima di poeta: par di sentire che scrive col cuore stretto e angosciato dal desiderio di capire quanto della sua vita e del suo genio sia stato formato in quegli anni infantili pieni di mistero. Ed è strano che questo mistero dell’infanzia non nella sua reale scomparsa (poiché mi permetta dirlo – lei non può ricordare quegli anni se non molto vagamente) ma come nuova creazione della sua fantasia straordinariamente sensibile, turbi la sua età matura, ricca di fantasmi ben più potenti, di contemplazioni ben più alte e di musiche ben più complesse. Però, come esserne addolorati, se da quel turbamento escono liriche così eccezionali? E lei trova in quelle rievocazioni un compenso per i tanti mali della vita? Ho letto le tre poesie con eguale piacere: mirabile mi sembra “La preghiera dell’angelo custode”, dove l’episodio è ricordato con arte purissima ed è poi elevato a una vasta significazione. Attendo vivamente l’annunciato volume di poesia. Mi ricordi e mi scriva. Con cordiale affetto».
D’altra parte, sia pure lontani, il rapporto tra Tamaro e Saba non era mai cessato. Lo confermano le minute di alcune lettere degli anni Trenta. Il diplomatico è a Helsinki quando gli scrive: «Caro Saba,quando ho ricevuto, oggi, la sua lettera, ho creduto che vi avrei trovato dentro qualche rimprovero, che sapevo ben meritato. Invece non c’erano che cortesie. Da molto tempo la devo ringraziare delle tre poesie, che mi ha mandato. Non so dirle che impressione mi faccia vederla ritornare con così appassionata insistenza al tempo della sua fanciullezza: si ha talvolta la sensazione che lei soffra oggi come soffrì allora, o, meglio, che soffra per quanto non poté soffrire in quel tempo lontano. L’estrema semplicità del verso non solo riproduce con vivissimo risalto la sua visione, ma ci mette anche in contatto immediato con la sua anima di poeta: par di sentire che scrive col cuore stretto e angosciato dal desiderio di capire quanto della sua vita e del suo genio sia stato formato in quegli anni infantili pieni di mistero. Ed è strano che questo mistero dell’infanzia non nella sua reale scomparsa (poiché mi permetta dirlo – lei non può ricordare quegli anni se non molto vagamente) ma come nuova creazione della sua fantasia straordinariamente sensibile, turbi la sua età matura, ricca di fantasmi ben più potenti, di contemplazioni ben più alte e di musiche ben più complesse. Però, come esserne addolorati, se da quel turbamento escono liriche così eccezionali? E lei trova in quelle rievocazioni un compenso per i tanti mali della vita? Ho letto le tre poesie con eguale piacere: mirabile mi sembra “La preghiera dell’angelo custode”, dove l’episodio è ricordato con arte purissima ed è poi elevato a una vasta significazione. Attendo vivamente l’annunciato volume di poesia. Mi ricordi e mi scriva. Con cordiale affetto».
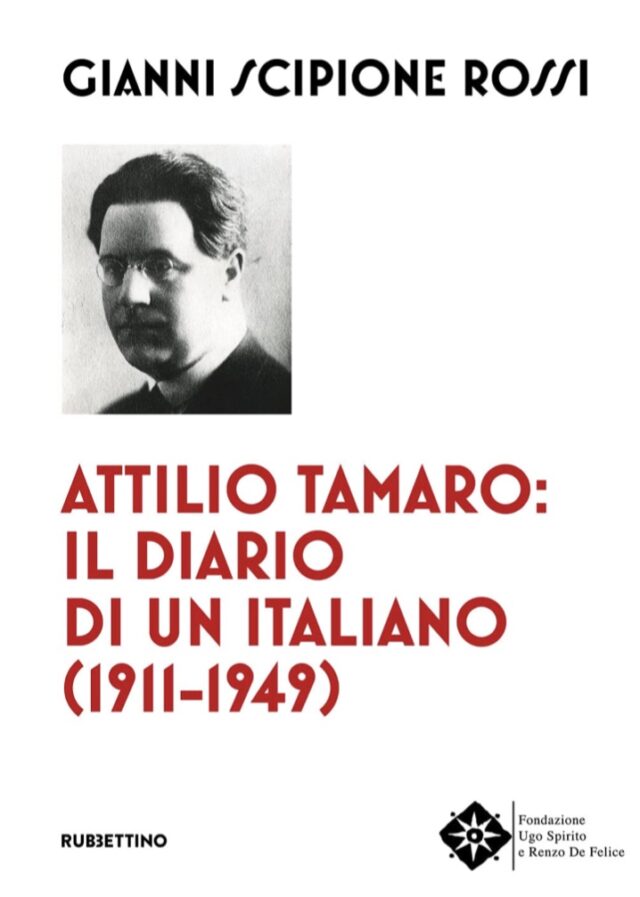
Nel 1933 Tamaro invitò Saba a lasciare Trieste e raggiungerlo a Helsinki. «Credo che per Lei – gli scrive – sarebbe meglio aver casa e lavoro a Trieste, ma viaggiare molto. So quanto è legato alla città e come ne senta profondamente le bellezze e le bruttezze e che cosa essa significhi per la sua poesia. Ma in fondo lei è prigioniero di Trieste e ora che il suo genio della poesia ha raggiunto in lei così mirabili perfezioni l’orizzonte ivi dev’essere troppo piccolo, le giornate troppo monotonamente eguali, gli uomini troppo sempre gli stessi, i soggetti troppo uniformi. […] Distaccarsi da Trieste le sarebbe un supplizio? Ma allora appunto deve almeno di tanto in tanto volare in altri cieli. Non le pare? O la mia predica la fa sorridere? Ma perché, per esempio, non verrebbe in Finlandia? Io sarei lietissimo di ospitarla e lei vedrebbe un paese e un mondo tutto diverso dal resto dell’Europa. […] Vuol venire? Andremo vedere boschi immensi e magnifiche cascate d’acqua e laghi senza fine e un popolo duro silenzioso povero ma superbo e forte. Vuol venire? Spero di sì. Con affettuosi saluti». Era il tempo in cui Saba era in analisi dallo psicanalista triestino Edoardo Weiss. Il poeta non raggiunse il diplomatico in Finlandia.
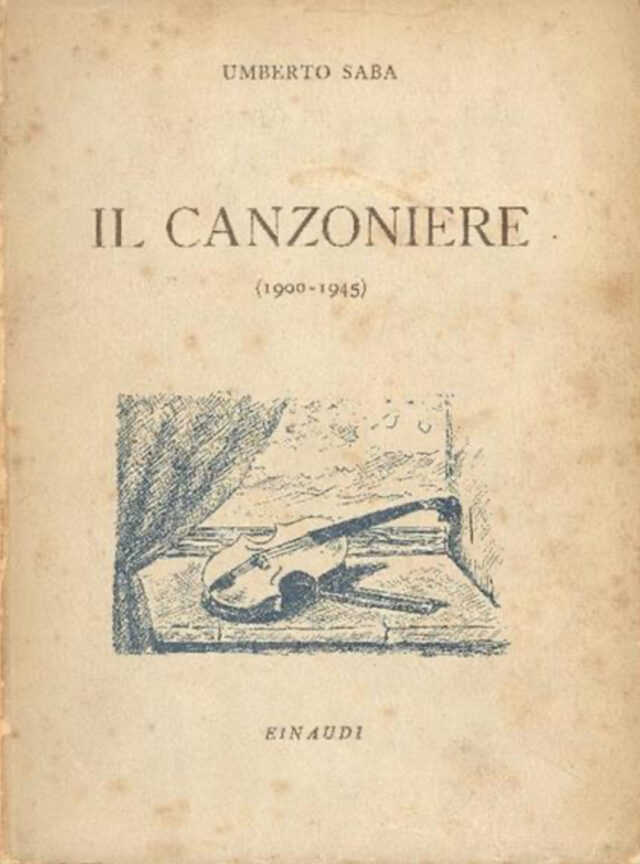 Va detto che anche Tamaro, per quanto la ami, vede Trieste come una sorta di gabbia affascinante e allo stesso tempo provinciale, se non proprio arretrata, come dirà Saba nella Storia e cronistoria del Canzoniere (1948), scritta in terza persona: «le origini triestine di Saba hanno avuto anche, come conseguenza, di farne, almeno agli inizi, un arretrato (Dal punto di vista della cultura, nascere a Trieste nel 1883 era come nascere altrove nel 1850). Quando il poeta era ancora giovanissimo, e già, in Italia come in tutto il resto del mondo, si preparavano o erano in atto esperienze stilistiche di ogni genere, la città di Saba era ancora, per quel poco che aveva di vita culturale, ai tempi del Risorgimento: una città romantica». Forse era una critica sopra le righe, ma in ogni caso era una percezione diffusa tra gli intellettuali triestini del primo Novecento, da Scipio Slataper a Giani Stuparich.
Va detto che anche Tamaro, per quanto la ami, vede Trieste come una sorta di gabbia affascinante e allo stesso tempo provinciale, se non proprio arretrata, come dirà Saba nella Storia e cronistoria del Canzoniere (1948), scritta in terza persona: «le origini triestine di Saba hanno avuto anche, come conseguenza, di farne, almeno agli inizi, un arretrato (Dal punto di vista della cultura, nascere a Trieste nel 1883 era come nascere altrove nel 1850). Quando il poeta era ancora giovanissimo, e già, in Italia come in tutto il resto del mondo, si preparavano o erano in atto esperienze stilistiche di ogni genere, la città di Saba era ancora, per quel poco che aveva di vita culturale, ai tempi del Risorgimento: una città romantica». Forse era una critica sopra le righe, ma in ogni caso era una percezione diffusa tra gli intellettuali triestini del primo Novecento, da Scipio Slataper a Giani Stuparich.
Trieste, nel 1948, non era ancora tornata italiana. Dovrà attendere il 26 ottobre 1954. In fondo pochi anni prima di quando ci arrivai io, Ma questo l’ho scoperto dopo. Due anni prima Nilla Pizzi vinse il Festival di San Remo con Vola colomba. I triestini e tutti gli italiani piansero: «Dio del Ciel, se fossi una colomba /
Vorrei volar laggiù dov’è il mio amor / Che inginocchiata a San Giusto / Prega con l’animo mesto / Fa che il mio amore torni, ma torni presto». Ormai questa è storia. Della storia triestina, però, fa parte anche la libreria di Umberto Saba. È riaperta. Questa volta non posso mancare, tornando ad assaporare un mondo sopra le righe.
Pubblicato anche su “The Social Post” il 26 gennaio 2025:
https://www.thesocialpost.it/2025/01/26/tornare-a-trieste-per-saba-e-non-solo/

